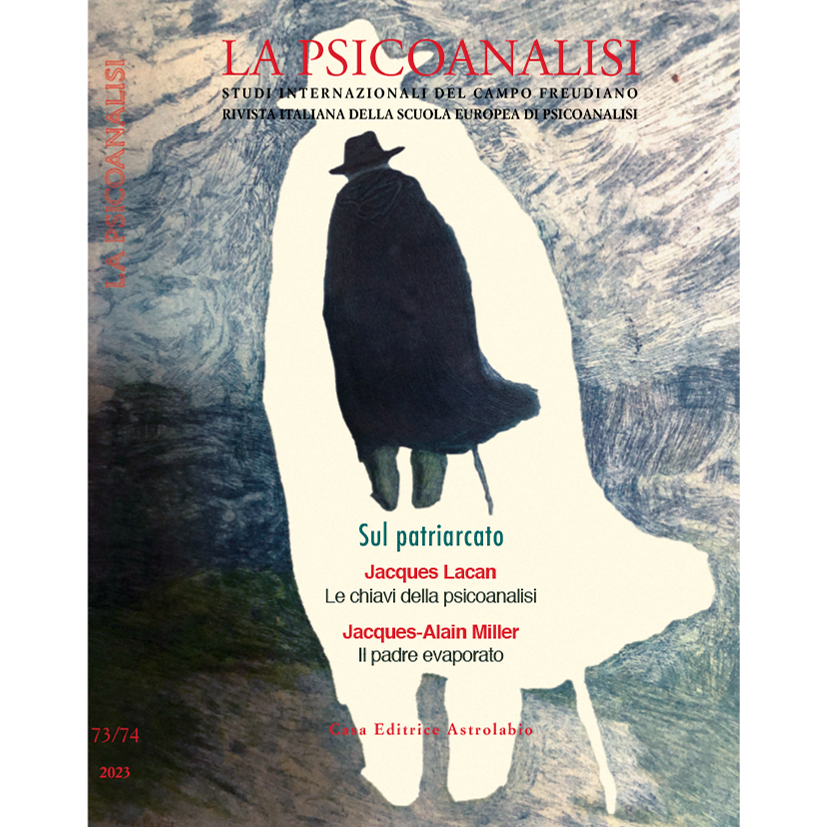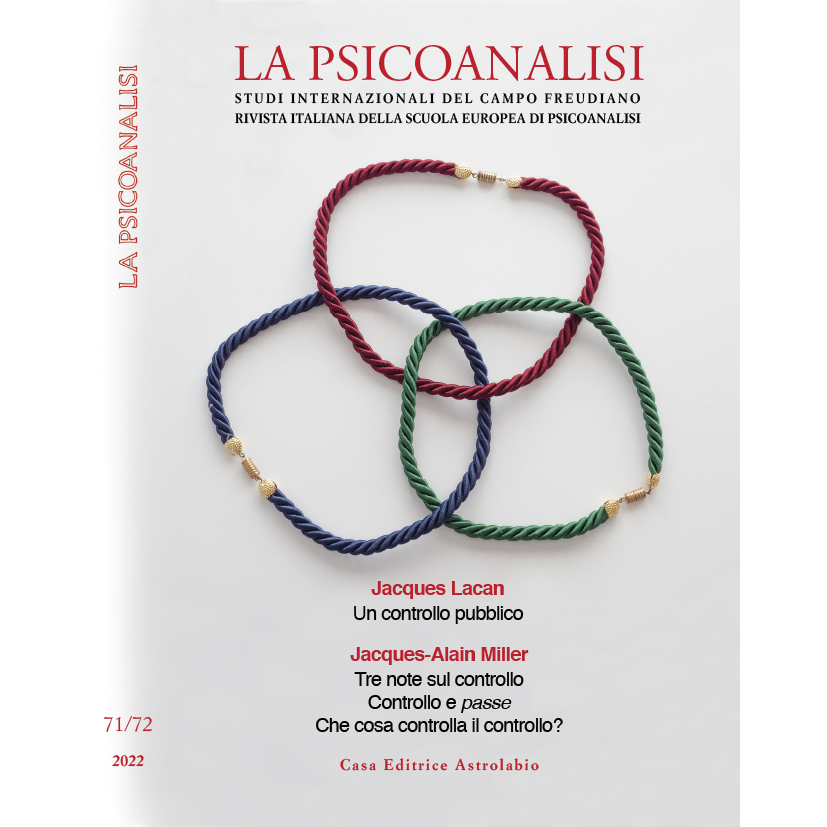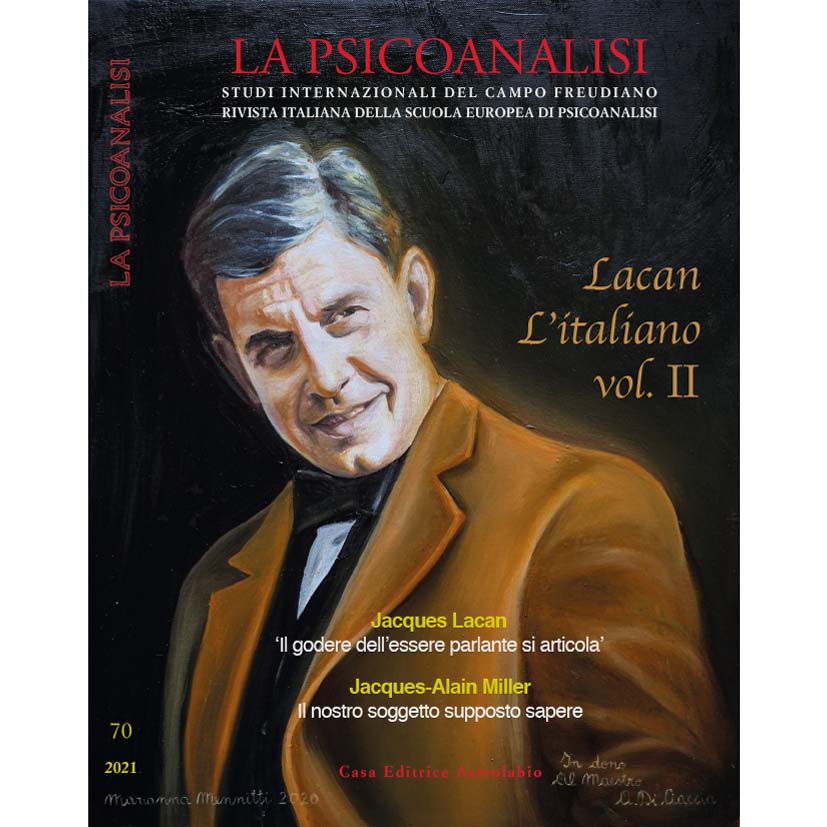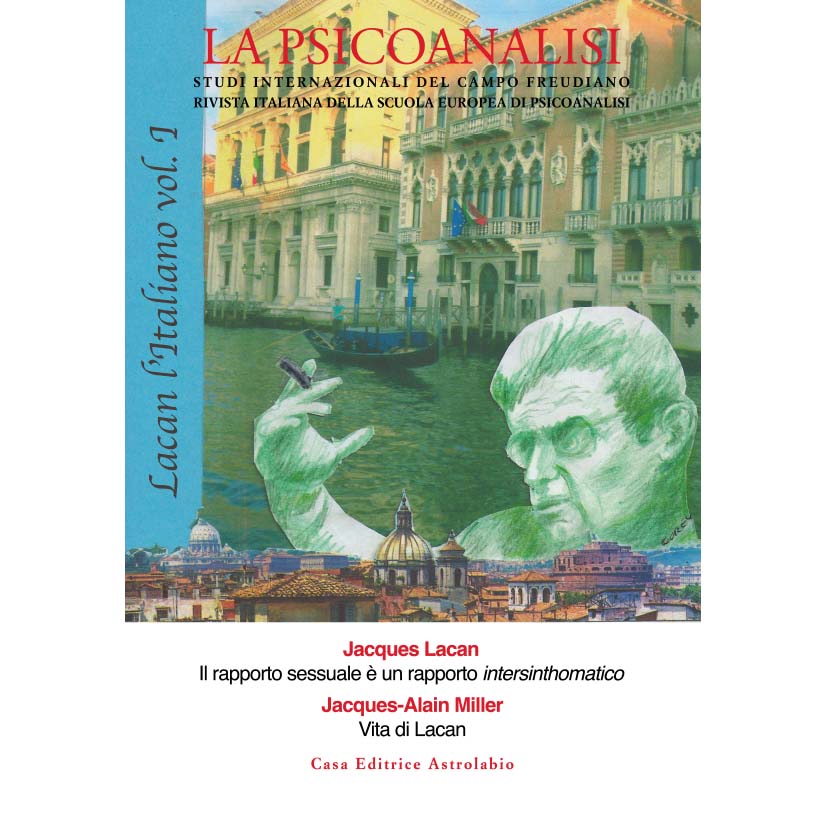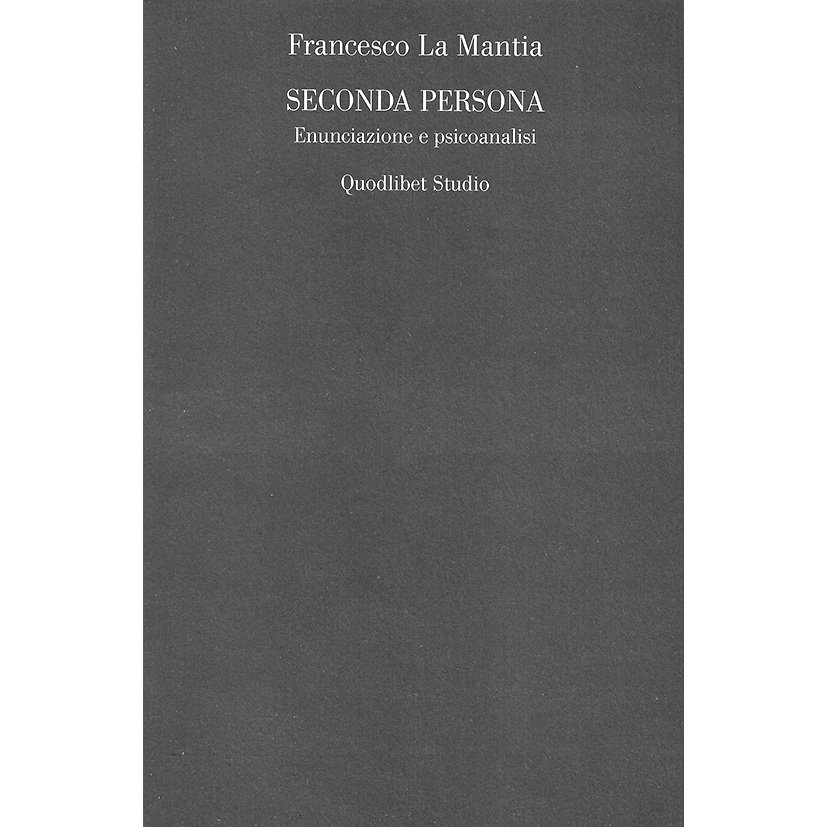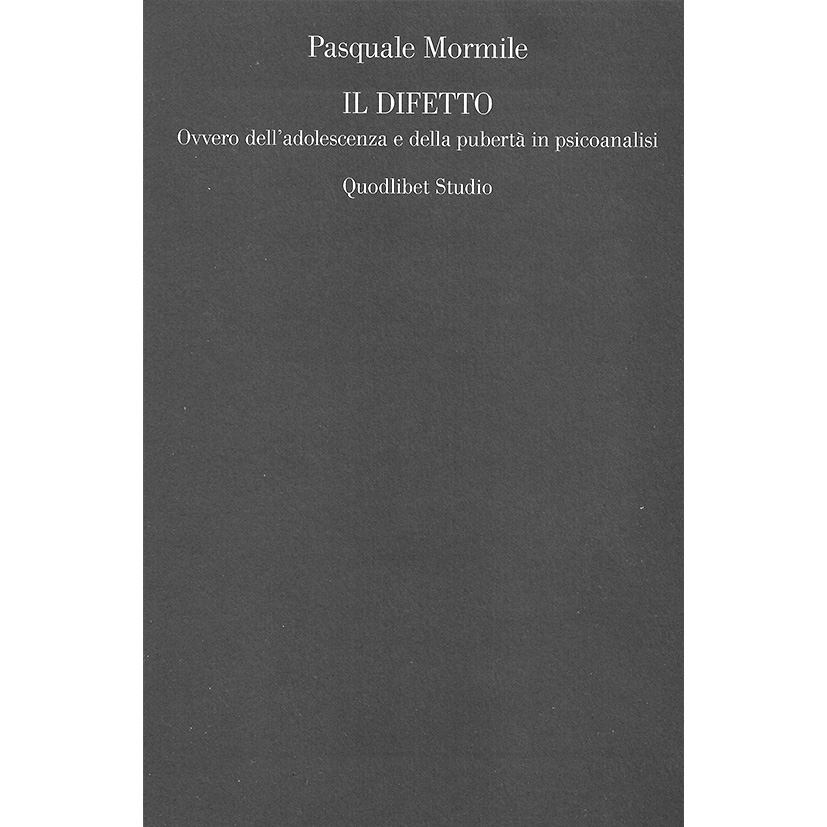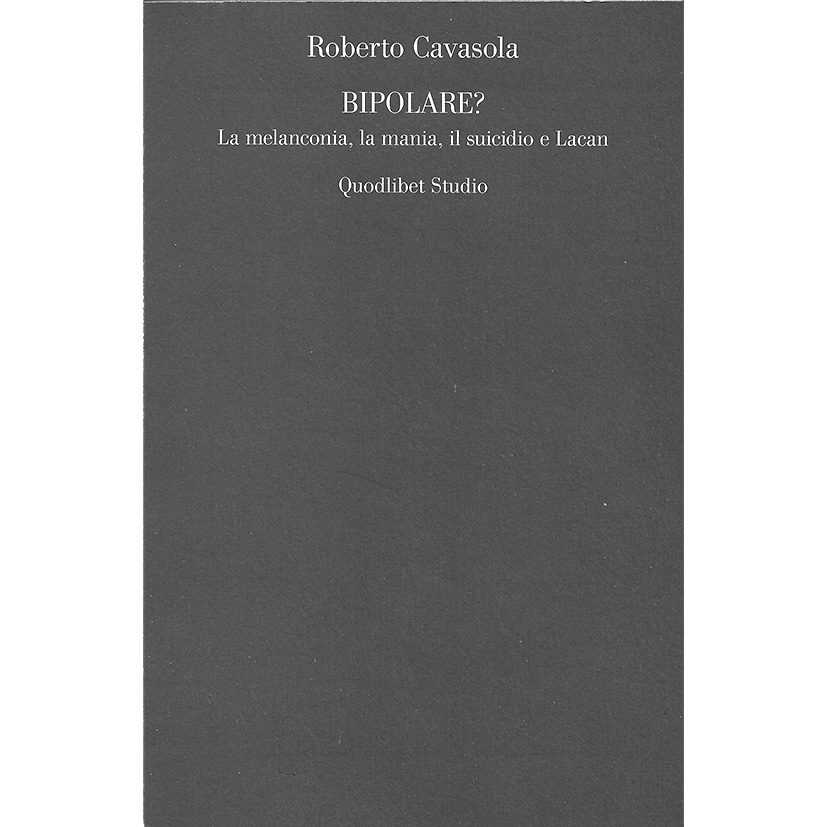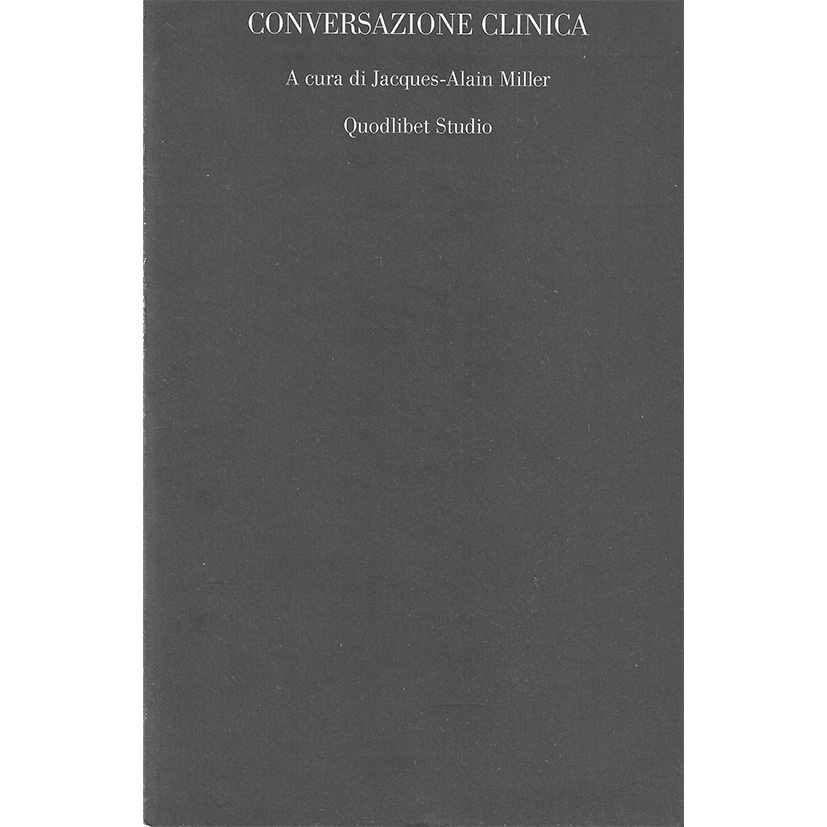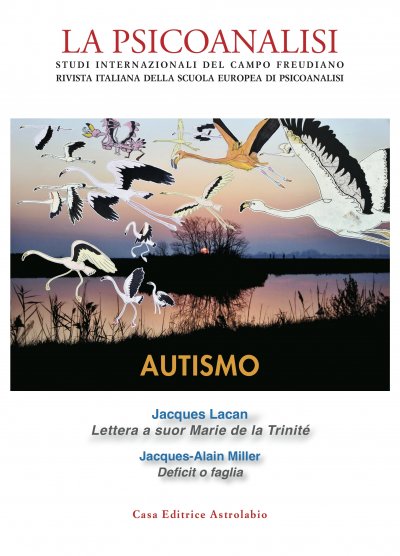71/72 gennaio-dicembre 2022
Nota editoriale
Le chiavi della psicoanalisi è il titolo che è stato dato a un’intervista che il Dottor Lacan aveva accordato in rue de Lille alla giornalista Madeleine Chapsal il 31 maggio 1957 per il settimanale francese L’Express. La nostra traduzione si basa sull’intervista così come è stata ripubblicata nel n. 99 de la rivista La Cause du désir.
Il lettore sarà meravigliato di trovarvi un Lacan che si esprime con grande semplicità e chiarezza, rispondendo con attenzione e precisione alle varie domande, senza tuttavia venir mai meno allo spirito e all’etica della psicoanalisi freudiana.
Sarà una delizia anche per il lettore non avvertito.
Abbiamo deciso di iniziare in questo numero il Corso di Jacques-Alain Miller tenuto al Dipartimento di Psicoanalisi dell’Università di Parigi VIII nell’anno accademico 1983-1984 dal titolo “1, 2, 3, 4”. Qui avremo solo alcune lezioni, le altre seguiranno nei prossimi numeri.
Già da tempo la nostra rivista aveva iniziato la pubblicazione di alcuni di questi Corsi, la cui serie era stata da Jacques-Alain Miller denominata “L’Orientamento lacaniano”. Le lezioni erano ordinate cronologicamente sebbene la pubblicazione seguisse l’opportunità offerta dai vari colleghi con le loro traduzioni. Di questi Corsi, dal 1992 in poi La Psicoanalisi ne ha pubblicati sette.
Rispondendo positivamente alla nostra richiesta, Jacques-Alain Miller tempo fa aveva accettato che “L’Orientamento lacaniano” venisse pubblicato in vari volumi per i tipi della casa editrice Astrolabio. Nelle librerie sono per ora disponibili l’ultimo di questi Corsi, ossia L’Uno tutto solo, del 2010-2011; il primo, dal titolo originale proposto dall’Autore, Capisaldi della psicoanalisi, del 1981-1982, e un terzo volume, Divini dettagli, del 1989. Altri due volumi, già tradotti, sono in attesa si pubblicazione: Delle risposte del reale, del 1983-1984, ed Estimità, del 1985-1986. Altri sono in traduzione. Comunque, in modo parziale, altri Corsi sono stati pubblicati, per esempio quello sull’Angoscia, casa editrice Quodlibet, o quello su Pezzi di reale, casa editrice Astrolabio, o anche il commento di Miller pubblicato nella nostra rivista sul Seminario Da un Altro all’altro di Lacan.
Su questa lunghezza d’onda abbiamo deciso di pubblicare la traduzione del Corso “1, 2, 3, 4” poiché vi si rende chiaro gli elementi che Lacan prende a prestito dalla logica e dalla matematica nel suo Seminario La logica del fantasma, ultimo uscito in Francia, e che il lettore potrà avere, in traduzione italiana per i tipi di Einaudi, nella prossima primavera.
In questo numero notiamo, tra i diversi articoli riportati, l’intervento introduttivo dell’ultimo “Pipol”, che si è tenuto a Bruxelles nel luglio 2023, e la tematica che vi ha sviluppato Jacques-Alain Miller.
Abbiamo voluto includere in questo numero un testo sulla verità di Christiane Alberti, attuale Presidente dell’Associazione Mondiale di Psicoanalisi.